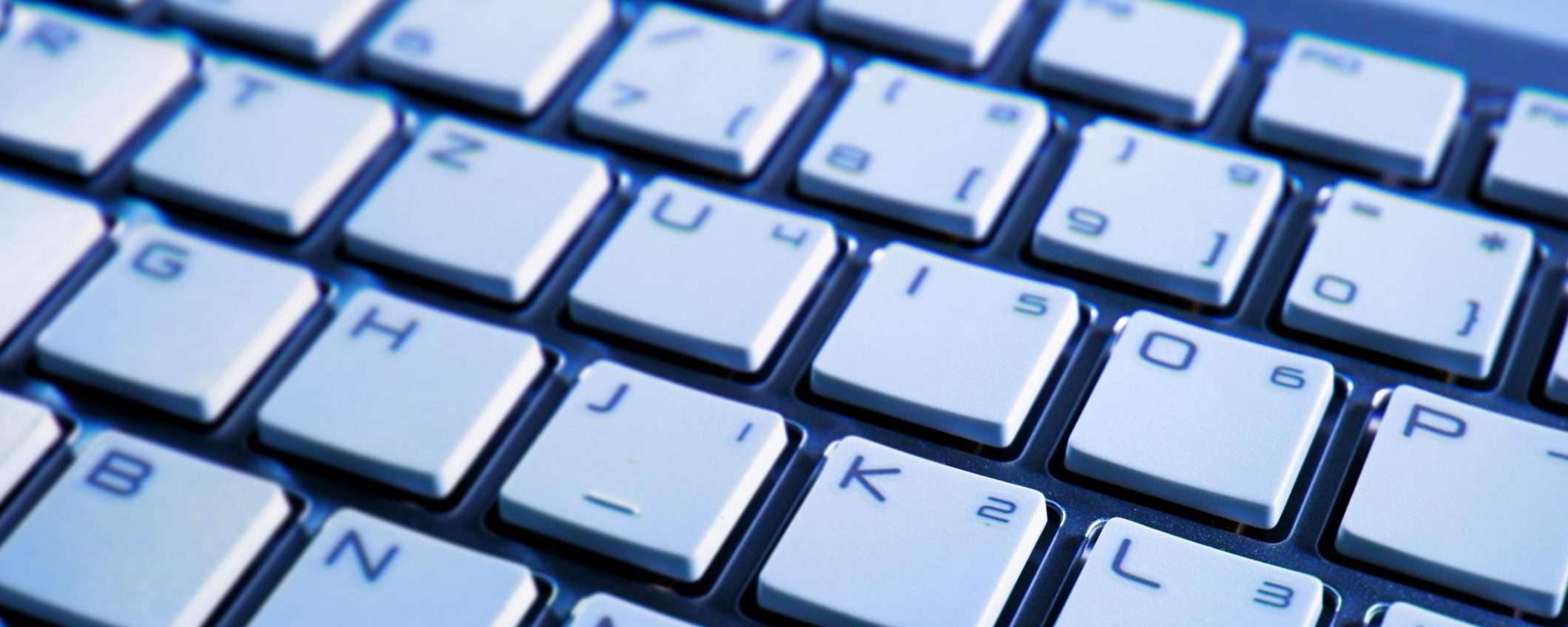Diciamolo, diciamocelo: non eravamo pronti. Ma andiamo oltre l’ovvio: certamente non si è mai è perfettamente pronti di fronte ad una emergenza – soprattutto se di questa magnitudo -, ma al tempo stesso se si fosse un minimo pronti ad affrontarla ci si potrebbe ricalibrare nel giro di poco tempo. Così, invece, non è stato. Nelle settimane in cui più si parla di smart working, ad esempio, tutto sembra ridursi più che altro ad un telelavoro di emergenza, con effetto temporaneo, con generale fastidio per questa prospettiva e con la sensazione per cui l’inerzia sia ben più forte sia dell’ambizione che della necessità emergenziale.
Si fa presto a dire smart working, ma mentre i singoli si attrezzano con postazioni di fortuna e grande pazienza, le aziende sono spesso inclini a seguire quanto già facevano prima che l’epidemia scoppiasse: chi era pronto si è presto convertito, chi non era pronto non si è ancora preparato. Dalle istituzioni, nel frattempo, è arrivato soltanto un timido incoraggiamento alla scelta dello smart working come semplice raccomandazione e poco più: nessun obbligo e nessun incentivo, solo una sorta di visione accompagnata da FAQ procedurali.
Il lavoro nella relazione della task force
In queste ore è stata pubblicata la relazione derivante dal lavoro della task force deputata ad analizzare le possibili azioni da intraprendere sul mondo del lavoro per ottimizzare le dinamiche della cosiddetta “Fase 2”. Dal testo emerge un quadro estremamente complesso e differenziato per il quale si consiglia, ad esempio, una analisi per “Sistemi Locali del Lavoro” (SSL) invece che superficialmente per settori d’attività. Insomma: non è possibile avviare singoli settori, poiché ad essere attivate devono essere intere filiere e non parti sconnesse di esse. Una volta analizzato l’SSL di riferimento, occorre valutarne gli impatti potenziali in termini di contagio e di rischio per le strutture sanitarie interessate, nonché la facilità di poter procedere con misure di protezione individuale e di distanziamento.
Lo smart working è citato? Si, ma en passant:
Sia in SSL aperti che in SSL chiusi, vanno supportate azioni volte a convertire, almeno temporaneamente, in tele- e smart-working tutte le attività per cui questo sia possibile, garantendo peraltro interamente le remunerazioni dei lavoratori.
Cosa si è fatto in proposito a livello istituzionale? Poco o nulla. Cosa hanno fatto le aziende in proposito? Nulla o poco. Ognuno si è mosso come isola a sé, mettendo in campo i rapporti fiduciari vivi all’interno dell’azienda, ma senza un passo realmente importante verso la dimensione dello smart working. Basterà interrogarsi sulla propria realtà e chiedersi: se si riaprisse domani, le cose sarebbero cambiate in modo permanente, o tutto tornerebbe alla situazione iniziale?
Non è comunque il caso di distribuir colpe, perché la sensazione è che fossero tutte ben antecedenti a quanto accaduto in questo inizio 2020. Il ritardo era cronico da molto tempo: in termini culturali e normativi, in primis. Il punto 10 della relazione, inoltre, spiega perché l’Italia abbia riaperto nonostante di fatto non sembrino essercene le condizioni:
La data in cui avviare la riapertura dipenderà dalla capacità del governo di implementare velocemente gli aspetti cruciali sottolineati sopra (disponibilità di dispositivi di protezione e test, sistemi di monitoraggio dei contagi e del livello di utilizzazione dell’infrastruttura sanitaria, provvedimenti di legge, etx). In ogni caso, va sottolineato che ritardare oltre l’inizio di maggio la riapertura potrebbe drasticamente esacerbare il disagio socio-economico del paese, già a livelli critici.
Insomma: sebbene ancora non siano disponibili dispositivi di protezione a sufficienza, nonostante i test sierologici non siano ancora affidabili, nonostante l’app di contact tracing non sia ancora disponibile, occorreva mettere in campo un certo margine di rischio appellandosi al senso di responsabilità dei cittadini e auspicando che nei buoni comportamenti si possa generare quel margine di tolleranza utile a recuperare sul tempo perduto.
Nel frattempo, però, la ricetta suggerita non sembra essere stata lo smart working, ma la riduzione dell’orario di lavoro per tenere più persone occupate con costi minori per il paese. Così, come noto, non è stato; così, come noto, non si è fatto realmente leva sullo smart working (per il quale non vi sono stati né obblighi, né incentivi) se non con raccomandazioni in realtà elargite fin da inizio emergenza e non certo a seguito della relazione della task force. Chi ha creato realmente opportunità di smart working lo ha fatto dal 4 maggio, data in cui le raccomandazioni son decadute e si son fatte largo le buone pratiche. Chi dal 4 maggio in poi ha posto in essere comportamenti virtuosi, però, in realtà era già culturalmente e tecnologicamente pronto da mesi; tutti gli altri non erano pronti e hanno soltanto tergiversato da remoto in attesa di potersi catapultare quanto prima nella normalità per capire come e se avrebbe calzato stretta.
Al punto 11 della relazione si raccomandava al Governo una “comunicazione delle basi razionali sottese ai diversi provvedimenti di apertura/chiusura“, perché far appello alla giustizia sociale avrebbe un ruolo chiave per garantire il successo dei provvedimenti intrapresi. “I cittadini non devono sentirsi in alcun modo vittime di scelte arbitrarie che determinino i loro diritti e obblighi riguardo la mobilità“. Anche in questo caso ci sembra chiaro come la fretta abbia dettato i tempi, perché di fatto proprio l’irrazionalità apparente di autocertificazioni e chiaroscuri del lockdown abbia permeato la narrazione dominante di questi mesi.
Non eravamo pronti, ma questa era una colpa antica. Ora siamo di fronte all’esame e ognuno dovrà rispondere con gli strumenti che ha. Lo smart working, si, anche lo smart working è uno di questi: la tua azienda era pronta?